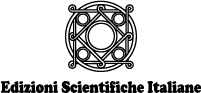Giurisprudenza nazionale ed europea e frammentazione legislativa della responsabilità civile del provider Le anti-suit injunctions nell’era della Brexit La donna nel diritto privato, oggi La visione della donna, per secoli considerata quale parte “debole” di un rapporto connotato verticisticamente dalla presenza di un “capo” e, dunque, come persona da proteggere, ha favorito, a livello giuridico, una disciplina dei rapporti familiari incentrata sulla differenziazione dei ruoli. La rottura con il passato si ha soltanto con la Costituzione del 1948, che sancisce la piena eguaglianza morale e giuridica dell’uomo e della donna, traducendosi così nell’eguaglianza dei coniugi. I principi costituzionali vengono in parte attuati con la riforma del diritto di famiglia del 1975. Tuttavia, non poche continuano ad essere le disparità di trattamento in contrasto con il principio di eguaglianza. In sostanza, attraverso la disamina delle relazioni familiari, del lavoro e dell’accesso alle cariche pubbliche, viene chiarito come il pieno riconoscimento sociale della parità fra uomo e donna non sia ancora giunto alla sua completa attuazione. ... [ acquista ] Ex iniuria non oritur ius: il freno delle Sezioni unite alla trascrizione degli atti di nascita L’interesse del minore quale unica certezza nell’odierno diritto di famiglia La disposizione di preferenza del testatore Il diritto successorio è governato da numerose istanze: tra i contrapposti interessi che connotano la materia spiccano, da un lato, la possibilità per il de cuius di esplicare la propria autonomia privata disponendo delle proprie situazioni soggettive; dall’altro, però, il rispetto del limite che l’autonomia del de cuius non può valicare integrato dalla tutela dei legittimari. Nel rispetto del diritto alla legittima – espressione della solidarietà familiare – il testamento, pur con i noti limiti, rappresenta lo strumento principe nel valorizzare l’autonomia privata sotto il versante mortis causa. Tra le diverse modalità tramite le quali si può valorizzare l’autonomia del testatore vi è la disposizione di preferenza, regolata dal secondo comma dell’art. 558 c.c.: la norma – nel disciplinare le modalità di riduzione delle disposizione testamentarie – sancisce che ‹‹se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari››. Tale previsione attribuisce rilievo alla volontà del testatore, salvaguardando – nei limiti della disponibile – le disposizioni predilette dallo stesso. Rilevante è, dunque, indagare i crismi in presenza dei quali la fattispecie può stimarsi integrata e le conseguenze a essa connesse. Il modello norvegese di corporate governance delle società pubbliche: spunti di riflessione per l’esperienza italiana Lo scritto analizza il modello norvegese di corporate governance delle società pubbliche, e lo confronta con l’omologo impianto normativo italiano. Il modello norvegese, che per molti tratti è simile a quello italiano, presenta però anche interessanti elementi di diversità, che vanno dalla disciplina dei compensi degli amministratori alla previsione di strumenti di compartecipazione dei lavoratori alla gestione della società, passando per il riconoscimento di ampi strumenti di tutela delle minoranze. L’aspetto che però più di tutti sembra distinguere il quadro normativo norvegese è la netta scansione di ruoli tra i vari soggetti coinvolti nel governo delle società pubbliche. Tali “specialità” della disciplina rendono la comparazione tra i due modelli ricca di sollecitazioni alla riflessione. ... [ acquista ] Le garanzie non possessorie di ultima generazione fra convivenze difficili e nuovi tipi: dal pegno del “decreto banche” alla “garanzia di Rordorf” del 2022 Le esigenze registrate nella prassi degli affari hanno portato i legislatori speciali ad allontanarsi, nell’ultimo cinquantennio, dall’archetipo tradizionale del pegno per arrivare alla codificazione di garanzie non possessorie assai variegate. Esondando dagli argini del Codice, gli interventi legislativi hanno edificato, da ultimo, il pegno non possessorio del “Decreto Banche” e la garanzia non possessoria della “Legge Rordorf”. Attraverso la disamina dei connotati delle due diverse forme di garanzie, l’Autrice ne mette in luce analogie e differenze e denuncia gli importanti problemi di “convivenza” di discipline simili nel nostro ordinamento, soprattutto in ragione delle diverse forme di pubblicità concepite ai fini della loro opponibilità, tracciando dunque utili spunti critici per la loro risoluzione. ...[acquista] Il concetto di difettosità nella realtà che cambia. Un esercizio di microcomparazione Attraverso un tradizionale approccio di microcomparazione, lo scritto ripercorre le principali tappe evolutive del concetto di difettosità dei prodotti con riferimento al sistema europeo ed a quello americano. L’intento è di far emergere alcuni spunti costruttivi per analizzare gli odierni lavori della Commissione europea, dedicati alla revisione della Direttiva in materia di responsabilità da prodotto. L’iniziativa del legislatore europeo è, sostanzialmente, volta a rivedere il concetto alla luce delle peculiarità dei prodotti della digital economy, ed in particolare della funzionalità dell’algoritmo. Una più ampia riflessione conclusiva sui risultati dell’analisi evidenzierà l’importanza di affrontare le questioni giuridiche inerenti alla realtà che cambia attraverso una combinazione di metodi, qualitativi e quantitativi, funzionale a cogliere il necessario adattamento del tradizionale concetto in esame alla complessità dei moderni prodotti. ...[acquista] Negozio giuridico e autonomia privata: Emilio Betti e la ridondanza non tautologica del sociale Le intuizioni di Emilio Betti in tema di autonomia privata hanno avuto un grande impatto sul pensiero e sulla cultura giuridica italiana. Di qui l’utilità di ripercorrere, con una adeguata contestualizzazione storico-politica, la sua teoria del negozio giuridico (Rechtsgeschäft) che, come noto, tentava di razionalizzare la tradizione romanistica con le esigenze di modernizzazione delle categorie e dei concetti giuridici. La rilevanza e la riconoscibilità sociale sono le lenti attraverso le quali l’interprete deve affrontare le molteplici espressioni dell’autonomia privata, perché l’ordinamento giuridico non è autopoietico. Il diritto è aperto al sistema sociale (apertura cognitiva) ed alla sua complessità dinamica: i fatti e i comportamenti sociali hanno un potere creativo infinito che non può esaurirsi nelle fattispecie giuridiche, anche se essenziali per la produzione di effetti giuridici (chiusura normativa). La persistente collisione tra fatto sociale e fattispecie giuridica resta quale monito costante di ricerca di razionalità nel discorso giuridico: dunque, quale perenne problema (e processo) culturale e non semplicemente tecnico. ...[acquista] Global take-down: deindicizzazione e territorialita’. Un nuovo caso Google alla Corte di giustizia L’autore analizza il caso Google c/CNIL che investe la questione della c.d. territorialità della deindicizzazione. La questione che viene esaminata concerne in particolare in quale ambito occorre limitare l’azione del motore di ricerca e che implicazioni può avere il nuovo GDPR. ...[acquista] Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa nell’età della rivoluzione informatica Negli ordinamenti contemporanei, la ricerca di sempre maggiori forme di partecipazione dei cittadini ai procedimenti decisionali pubblici si inserisce nel quadro di un rapporto di integrazione tra il modello tradizionale della democrazia rappresentativa ed il nuovo modello della democrazia partecipativa come valorizzato da internet. Pur trovando applicazione presso tutti i livelli di governo, le pratiche e le esperienze partecipative di nuova generazione prediligono l’ambito sub-statuale tanto negli ordinamenti di common law quanto in quelli di civil law. In tale prospettiva, le rinnovate forme di partecipazione tramite internet devono necessariamente svolgersi nel perimetro delle garanzie e dei controlli propri degli schemi della rappresentanza, contribuendo così al rafforzamento delle Istituzioni democratiche e alla loro apertura verso la società civile. ...[acquista]
Salvatore Sica
Il contributo affronta il tema della responsabilità degli Internet provider nel quadro del dialogo tra giudici nazionali e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, declinandolo con riferimento al profilo più generale del sistema delle fonti multilivello dei diritti nazionali all’esito del processo di unificazione. Attraverso l’analisi critica dell’apporto giurisprudenziale costantemente fornito dalle Corti europee e nazionali, l’autore sintetizza un quadro di permanente incertezza interpretativa, reputando indispensabile la riaffermazione e il consolidamento di regole giuridiche condivise.
(novembre 2019)
... [ acquista ]
Rita Lombardi
L’Autore esamina le anti-suit injunctions inglesi - provvedimenti inibitori tipici dei sistemi di commow law, attraverso i quali il giudice ordina ad una parte, sotto pena della sanzione del contempt of court, di non avviare o proseguire un processo davanti ad un giudice appartenente ad un ordinamento straniero o ad un tribunale arbitrale internazionale - nella specifica prospettiva delle possibili ricadute che su di esse avrà dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. A seguito dell’analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e di quella inglese in ordine alla compatibilità delle anti-suit injunctions con il sistema giuridico dell’Unione europea, l’Autore segnala che con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea il potere del giudice inglese di emettere tali provvedimenti nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea pare destinato a riattivarsi. E però la problematica è destinata a soluzioni diversi in dipendenza degli esiti del percorso sulla Brexit
(novembre 2019)
.... [ acquista ]
Gabriella Autorino
(novembre 2019)
Gisella Pignataro.
(settembre 2019)
La configurabilità di un nuovo modello di filiazione a base essenzialmente volontaristica, effetto del progresso scientifico che ha sottratto l’evento nascita al dominio esclusivo delle leggi naturali, è smentito dal sistema. Dall’analisi della prassi giurisprudenziale, che ha autorizzato la trascrizione di atti di nascita redatti all’estero anche con la surrogazione di maternità, emerge l’attribuzione al diritto di una mera funzione rimediale, non sempre coerente con i principi di indisponibilità dello stato e di rispetto dell’identità della persona. Il freno delle Sezioni unite a forme di automatismo, confrontato con altre realtà nazionali e la cautela della Corte europea, è occasione per puntualizzare i concetti di favor minoris e di interesse alla conservazione dello status acquisito all’estero in assenza di un legame genetico, nel tentativo di oggettivare il contenuto normativo dell’interesse del minore senza rinunciare alla coerenza del sistema. ... [ acquista ]
Maurizio Di Masi
(settembre 2019)
Il contributo analizza come il mutamento dei paradigmi sociali e le innovazioni biotecnologiche hanno esposto il diritto di famiglia ad una crisi delle categorie privatistiche tradizionali, a cui si è risposto col ridisegnare le relazioni familiari attraverso la clausola generale del miglior interesse del minore. Il risultato operazionale cui si perviene è che la famiglia che il diritto oggi tutela, sempre più, prescinde dalla coppia e dai suoi singoli membri – siano essi sposati o meno, eterosessuali oppure omosessuali – per dar preminente rilievo allo status e all’identità del minore, come i recenti approdi giurisprudenziali in tema di gestazione per altri e/o di omogenitorialità ben evidenziano. Il best interest of the child, dunque, diviene parametro per la creazione di un regime giuridico parallelo a quello matrimoniale, volto ad attribuire certezza ai rapporti genitoriali pur nella molteplicità e nella fragilità dei modelli familiari. ... [ acquista ]
Giorgia Anna Parini
(settembre 2019)
... [ acquista ]
Francesco Cuccu
(settembre 2019)
Rachele Marseglia
(settembre 2019)
Giorgia Guerra
(settembre 2019)
Camilla Crea
(settembre 2019)
Carloalberto Giusti
(settembre 2019)
Gabriele Papa
(settembre 2019)